|
RECENSIONI
Giuseppe Tucci una vita nomade a caccia del mito- di Bernardo Valli - Domenica di Repubblica 4 settmebre 2005
In Nepal scrive: “Il silenzio sospeso nell’aria vegliava, solo, sul luogo dove era nato Gauthama Siddhartha che doveva, dopo il suo risveglio spirituale, diventare Budda”.
Ai piedi del Potala, nel tardo autunno di due anni fa, socchiudo gli occhi e lascio alla fantasia il compito di ricostruire Lhasa cosi come era nel 1948, quando Giuseppe Tucci vi mise piede per l’ultima volta. Ho appena letto la sua descrizione, ed anche di altri, in particolare quella meno aristocratica e più passionale di Alexandra David - Néel della stessa epoca.
La città, cresciuta senza un piano, prestabilito, è popolata da gente di tutte le razze e vestite in tutte le fogge. È una tavolozza di colori sui quali prevalgono il rosso e il giallo. Sulle piazze e le strade scorre un fiume umano in piena: pellegrini, mercanti, mendicanti, asceti si confondono con uomini e donne del posto; si muovono come un gregge senza pastore, in direzione di pagode cariche d’oro e gremite di statue, tra i cumuli di rifiuti e le fosse che servono da latrine, esposte a tutte le curiosità e a tutte le intemperie. La luce nobilita anche gli angoli più luridi. La luce del Tibet non è paragonabile a nessuna altra. L’azzurro intenso del cielo e il bianco antico delle montagne innevate si contendono il ristallo dello spazio. Il sole accende i colori senza attenuare il gelo, che quasi non si sente tanto è asciutto. Con la sua mole massiccia, il Potala protegge la città e domina l’intera valle tagliata dal corso del Chiciu e serrata a nord e a sud da montagnenude, quando non sono coperte di neve.
Là, oltre la città, si stende un paese silenzioso e strano; geloso dei suoi segreti; apollaiato sul tetto della Terra, l’altare del mondo, a un’altitudine che può uccidere chi vi sale partendo dal livello del mare; allungatosusteppesterminate, costellate di laghi la cui acque gelate sono di un blu più intenso di quello del cielo.
Quando riapro gli occhi, per alcuni minuti tengo alto lo sguardo, lascio che si perda nello spazio in cui si riflettono colori eterni e inviolati. Cerco di non disperdere subito le immagini recuperate dagli scritti dei viaggiatori di un tempo. Concludo il gioco infantile ritornando al traffico, automobilistico e umano, simile a quello di tante altre città della Cina. La Cina che ha inghiottito il Tibet conosciuto da Giuseppe Tucci, riducendolo a un paese
come tutti gli altri. O quasi.
Tucci ha avuto la fortuna di esplorare, di conoscere, di studiare quel Tibet in gran parte scomparso. Vi aveva trovato una terra promessa, un rifugio per evadere dall’Occidente industrializzato e in generale dalla sua modernità, che aborriva.
Aveva partecipato alla Prima guerra mondiale e l’esperienza l’aveva spinto, come altri giovani ufficiali, verso il fascismo. E questo lo induceva a pensare che la battaglia, l’azione, il rischio, fossero «un antidoto alla fredda razionalità e alla
spersonalizzazione dell’era contemporanea ». Anche la conoscenza delle religioni orientali poteva servire a immunizzare l’Occidente da quei mali che l’avrebbero portato a un’inevitabile decadenza. Per salvarsi la civiltà europea doveva attingere forze e idee dalla civiltà asiatica. Il Tibet, per la sua inviolata autenticità, era l’antidoto per eccellenza. Era incontaminato.
Immobile nella sua perenne, preziosa, incantata antichità. Qualcosa di simile a uno scrigno smarrito, dimenticato, lassù, sulle vette più alte. Irraggiungibile per gli affannati comuni
abitanti delle metropoli occidentali a corto di fiato.
Le difficoltà materiali per raggiungerlo ed esplorarlo, e il lavoro intellettuale per aprirlo e decifrarne il contenuto, impegnavano tutte le sue doti e sollecitavano le sue ambizioni, eccezionali e sconfinate. Il fisico, l’intelligenza, la cultura (conosceva le principali lingue europee, il cinese, il sanscrito, il tibetano, l’hindi e vari antichi idiomi asiatici), e una passione alimentata da una vanità incontenibile, gli consentivano di affrontare avventure perigliose e imprese scientifiche rimaste esemplari, per gli studiosi dell’Asia (un tempo
chiamati orientalisti).
L’immagine che si ha di lui assomiglia a quella di un superuomo, cosciente di essere tale. E quindi superbo. Non sempre simpatico. Altezzoso. A tratti arrogante. Cosi mi apparve quando lo incontrai e non mi lasciò neppure il tempo di porgli una domanda. Parlò per più di un’ora. Ma non mi pentii di averlo ascoltato in silenzio. Era anche un seduttore.
Alla fine sentii una profonda riconoscenza per il tempo che mi aveva concesso.
A trent’anni, grazie a Carlo Formichi, suo professore di sanscrito, Tucci ottiene la cattedra di lingua e letteratura italiana all’Università indiana di Shantiniketan, fondata da Rabindranath Tagore. E in quel periodo traduce dal cinese e dal sanscrito vari testi classici.
Ma l’esperienza in quell’università non dura a lungo. L’interrompe un incidente al quale lui è personalmente estraneo.
Tramite Carlo Formichi, il governo italiano invita Tagore a Roma, e durante la visita il poeta si indigna per il modo in cui la stampa affianca fascismo e nazionalismo indiano, e rompe ogni tipo di collaborazione con l’Italia. I tentativi di sfruttare i richiami di Gandhi (e di Nehru) al Risorgimento italiano, e in particolare a Mazzini, si ripeteranno anche negli anni seguenti,
da parte di Carlo Formichi, il cui obiettivo era appunto di alleare fascismo e nazionalismo
indiano in funzione anti britannica.
Costretto a lasciare l’università di Tagore, Tucci resta comunque a Calcutta e poi a Dacca con vari incarichi universitari e pubblica alcuni saggi sul confucianesimo e il taoismo. L’esibita fede fascista gli servirà poi per ottenere i finanziamenti indispensabili alle sue spedizioni. Per questo non esiterà a sottoscrivere il documento del regime sulla condanna della razza ebraica. Tuttavia la passione per le esplorazioni e la ricerca scientifica prevarrà ampiamente,
consentendogli alla caduta del fascismo di far apparire quella ideologia più strumentale
che autentica. L’indiscutibile valore dei suoi studi, e il prestigio internazionale,
contribuiranno a ristabilire molto presto la sua autorità anche sull’Ismeo (Istituto per il Medio ed Estremo Oriente) da lui fondato nel ‘34, con Giovanni Gentile.
I suoi studi restano oggi un punto di riferimento per chiunque si occupi di Tibet e in particolare di arte tibetana. Come vengono riconosciute e celebrate alcune sue scoperte archeologiche, anche in Cina, in Iran, in Pakistan, nel Nepal.
Tucci amava la vita nomade. Nella raccolta di suoi scritti appena pubblicata, con una introduzione di Stefano Malatesta (Il paese delle donne dai molti mariti, Neri Pozza, euro 17,50), racconta «l’irrequietezza mai sazia» che gli faceva detestare fin da ragazzo le pareti domestiche e prediligere il vagabondaggio come forma di vita. Gli esempi di due concittadini, entrambi nati come lui a Macerata, l’hanno subito spinto verso l’Oriente. La grande avventura intellettuale di Matteo Ricci in Cina nel tardo Cinquecento, e quella di Cassiano Beligatti in Tibet nel Settecento, hanno acceso la sua fantasia d’adolescente.
Amava le carovane, la solitudine sulle alte valli del Tibet, del Sikkim, del Nepal, e le avventurose indagini per arrivare a un manoscritto o a un dipinto.
Nel ‘52, quando ha cinquantotto anni, dopo una marcia di quaranta giorni dalla frontiera tibetana, Giuseppe Tucci arriva in prossimità di Rumindei (oggi Lumbini, nel Nepal). È il 27 novembre ed è già il crepuscolo.
Il sentiero polveroso sul quale avanza nella pianura monotona sembra senza fine. I soli rilievi in cui inciampa lo sguardo sono due leggere prominenze, due timide gobbe, che nella luce metallica del tramonto sembrano un trepidante miraggio destinato a sparire in quella
sconfinata solitudine.
«...Il silenzio sospeso nell’aria vegliava, solo, sul luogo dove era nato Gauthama Siddhartha che doveva, dopo il suo risveglio spirituale, diventare il Budda». Cosi uomini caduti nelle sue battaglie vittoriose, viene in pellegrinaggio a Rumindei per cercare la pace nelle parole di Siddhartha.
Tucci è affascinato da quella celebre conversione del sovrano tormentato dal rimorso per la violenza delle guerre in cui ha trionfato.
Anche lo studio del buddismo (tantrico, cioé iniziatico ed esoterico) che incontra in Tibet conduce Tucci a qualcosa di molto simile a una conversione. Ma non a una conversione totale. Le sue restano le incursioni di un occidentale.
Egli si tuffa nell’Oriente ma non vi si perde. Non si lascia inghiottire.
Per lui le scuole di quel tardo buddismo, annidate nei grandi monasteri (in cui ama soffermarsi
e discutere, conquistando i monaci con la sua conoscenza della loro lingua e della loro cultura), sottopongono a un’acuta analisi il nostro io e servono a enucleare
dall’imperfetta creatura che siamo un essere perfetto al di là di ogni contingenza e dolore.
Ma la teologia e la metafisica di quelle scuole, pur avendo una poderosa impalcatura
logica, devono dimostrare anzitutto la falsità delle opinioni e delle teorie correnti, e condurre alla conclusione che il vero è oltre la formula logica, non oggetto di conoscenza, ma di esperienza. Tucci trova sul tetto del mondo un alleato contro il razionalismo dei suoi contemporanei
occidentali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Gli dei di burro
Nel Tibet di Giuseppe Tucci
Quando si visita un monastero buddista bisogna procedere con molta cautela, in particolare se non si è ancora svolta o si sta svolgendo la funzione mattutina. E con moltissima cautela bisogna puntare la macchina fotografica. Escluso sempre in maniera tassativa di farlo all'interno dei templi, anche all'aperto ci si troverà ovunque davanti qualche monacello imberbe e imbronciato, di stazza minuscola ma compatta, che ci mulina l'indice sotto l'obiettivo esplodendo certi gutturali ”No, no“ che preludono al cupo salmodiare lo “Om Mani Padme Hum“ in tonalità degne di Scialiapin. Poi magari nel pomeriggio ti corrono dietro per farsi fotografare abbarbicati a te, cercando di parlare di football e di scrivere faticosamente un indirizzo mail a cui mandare la foto, ma il mattino, in attesa della preghiera, niente da fare.
Anche nei cavernosi recessi del monastero trovi sempre un monacone rasato a zero e drappeggiato nella tunica rossa che ti sventola severo il dito sotto il naso: ”No photo, no photo“. Finché inopinatamente, sulla porta di uno dei tanti antri, ampio e coloratissimo, il monaco di turno ti dice che, sì, lì puoi fotografare tutto quello che vuoi. Tu rimani di stucco, perché sei circondato da un policromo tripudio di immagini sacre votive, che mai penseresti di poter dissacrare con il tuo flash. Invece sono soltanto RAPPRESENTAZIONI del sacro, NON il sacro in sé, che non può consustanziarsi in un oggetto appartenente all'illusorio ambito del reale. Al contrario, dunque, il flash, con la sua luce, e la tua presenza, con il suo calore, contribuiranno al modificarsi di tale rappresentazione fino al suo disfacimento e al conseguente passaggio nel vero reale, il vuoto. Perché - come del resto avrebbe dovuto avvertirti il sentorino quasi di piedi - le bellissime (o anche truci) e coloratissime immagini sono fatte con il più deperibile dei prodotti, il burro, sia pure di yak.
Foto a parte, tutto ciò viene spiegato con impareggiabile maestria in Il paese delle donne dai molti mariti di Giuseppe Tucci, grande specialista di filosofie orientali e in particolare di buddismo e cultura tibetana, uno dei più grandi al mondo. Grandissimo ma non precisamente indimenticato, in Italia. Se si effettua una ricerca nella più importante libreria virtuale del nostro paese, compaiono al massimo cinque titoli, di cui uno indisponibile. Se invece lo cerchi su Amazon americana, ti viene scaraventato sotto il naso lo stupefacente numero di poco meno che 600 titoli, sia pure in buona misura doppioni o in lingue diverse o di disponibilità limitata (e probabilmente qualcuno di quei Tucci non è lui). «Il Tibet, Tucci?» si sentirebbe chiedere oggi se proponesse un suo testo a una qualsiasi pubblicazione di qui. «A chi interessa? Va be', al massimo un paio di cartelle, visto che ha queste foto di moda e modernariato tibetani (ce le dà gratis, vero?), ma non si diffonda come al solito in quelle sue mortali disquisizioni su arte, cultura e religione. Chi le legge? Sia breve e lieve, diverta...» Doppiamente meritevole, quindi, il lavoro di chi ha raccolto questi anche ardui testi per riproporli al lettore italiano di oggi.
Quanto ”io“ c'è nei racconti del professor Tucci: ”Io che ho fatto questo, io che ho scoperto codesto, io che ho decifrato quello“ eccetera. Per quanto sia tutto verissimo e certificato, non sembra un atteggiamento precisamente da persona aspirante a dissolversi nella suprema realtà del vuoto buddista, ma tant'è. D'altra parte il professore esigeva sempre di essere chiamato Eccellenza e ci teneva moltissimo a far sapere quanto fosse potente nella Roma fascista. I testi sono comunque affascinanti, e possiamo soltanto sperare che ne seguano presto altre raccolte e riedizioni. Perché Il paese delle donne dai molti mariti? Perché nella società tibetana vige la poliandria. Ogni donna ha non soltanto il proprio marito ma anche i fratelli di questo: le condizioni di vita sono durissime, il marito può sparire da un momento all'altro tra il ghiaccio o in un crepaccio, calpestato da uno yak, sotto una valanga o una frana, tanto vale adattarsi fin dal principio all'idea e attrezzarsi. Se n'era accorto persino il corrucciato Sven Hedin, che pur avendo eletto a propria ”fredda sposa“ l'Asia, ammette che con una certa promiscua sposina, in un certo angolo del Tibet, potrebbe anche essere successo qualcosa. Una, in diverse decine di anni di esplorazioni: che resistenza. Si può perdonargli la scappatella e auspicare soltanto che un giorno qualcuno traduca in italiano lo splendore delle sue memorie intitolate ”La mia vita da esploratore“. Mentre le compilava non era ancora stato preso dal demone del nazismo.
Hedin, Tucci, tanti altri amici di Hitler e Mussolini... Che cosa facevano tra quelle altissime vette, con i ramponi ai piedi o in groppa a uno yak? Davvero si limitavano a esplorare? C'è da dubitarne. Controllare il Tibet avrebbe significato, per le potenze tese a coalizzarsi nell'Asse, provocare un bel grattacapo per i britannici dell'India, approfittando della temporanea debolezza della Cina, sgravata dell'imperatore ma in sanguinosa guerra civile. La consuetudine di Tucci con Karl Haushofer è perlomeno inquietante, ma bisogna ammettere che il professore soprattutto studiava culture, religioni e arti dei paesi che andava letteralmente arando con i tracciati delle sue spedizioni. Infatti l'Italia uscita dal fascismo continuò giustamente a finanziare le sue ricerche. Così oggi possiamo godere dei testi raccolti in Il paese delle donne dai molti mariti, che spaziano su un arco temporale che va dai Trenta ai Cinquanta.
”Visioni“ e ”Incanti“, montagne e deserti, giungle e fiumi, divinità e demoni, buddismo e induismo, tutto si compone a formare un unicum straordinario teso anzitutto a fare da ambiente per l'uomo e il suo ”dolore dell'esistere“, che nell'immediato sembra tuttavia essere ”piacere dell'esistere“ se non addirittura ”furia dell'esistere“. Così le donne dai molti mariti e il turbinoso cromatismo delle immagini di burro, le risate senza freno e il fervere di avidi mercati dentro il tempio, dove in un angolo neanche dei più remoti o bui puoi avvistare un gruppetto di monaci ingobbiti come nibelunghi a contare e impacchettare i mucchi di banconote depositate come offerte sugli altari. Poi esci dalla cupezza rimbombante di ”Om“ e Tucci ti guida per mano tra gli edifici e le celle del monastero, e poi fuori, nel villaggio o nella città, fin dentro le case, con la loro struttura a volte impensabilmente prospera, i loro oggetti d'arte, i mobili, le masserizie. Persino nelle dimore di nobili, grandi lama e re.
Conclude il libro lo straordinario racconto di una ”kora“, il pellegrinaggio da effettuare in senso orario (se si è buddisti, al contrario se si è seguaci della precedente religione Bon del Tibet) in circa 3 giorni. Ma Tucci ce ne mette molti di più, su e giù, di monastero in monastero, attorno al Kailash (6600 metri, ”Kailasa“ lo chiama lui), la montagna più sacra dell'Asia, venerata allo stesso titolo da buddisti e induisti, per i quali è il Paradiso di Shiva. Sembra di essere lì, appena sopra le cristalline acque del lago Manosarovar, avendo negli occhi la visione degli ex voto schiaffeggiati dal vento e negli orecchi il cigolio dei mulinelli di preghiera. Applausi alle visionarie capacità evocative di Giuseppe Tucci e a chi ha avuto l'idea di riproporlo, soprattutto in questa epoca oscura in cui - nella nostra insopprimibile ansia di provincialismo - sembra che gli unici degni di attenzione quando scrivono di viaggio siano gli stranieri.
Mario Biondi - Infinite storie
Settembre 2005
============================
Giuseppe Tucci - Un Himalaya di conoscenze
di Lorenzo Scandroglio - Il Giornale
Chi non sa che quello ritratto in alcune foto seppiate degli anni Dieci e Venti del Novecento è Giuseppe Tucci da giovane, per un attimo potrebbe quasi pensare che si tratti di una giovane donna in abiti da viandante, questi sì maschili, con calzettoni di lana grossa, scarponi di cuoio, pantaloni arrotolati sotto il ginocchio, alla zuava, giacca pesante e bastone. L'impressione si deve a quel ciuffo di capelli neri, che si alzano di lato e ricadono sulla fronte, su un viso dai tratti delicati. L'immagine di sé che Tucci ha consegnato alla storia ce lo mostra però due-tre decenni dopo, impegnato nel guado di fiumi, solo o al fianco di portatori tibetani, guardiani di monasteri, arcieri dai tratti inconfondibilmente asiatici, con il volto che tutti, tibetologi, etnologi, esploratori, orientalisti, hanno imparato a riconoscere: le sopracciglia leggermente cadenti e gli occhi socchiusi di chi è abituato a protendere lo sguardo verso l'orizzonte.
Forse meno noto al grande pubblico del suo amico-nemico Fosco Maraini (col quale ruppe i rapporti, complice un carattere e un'indole non prive di asperità, per aver messo gli occhi sulla stessa principessa tibetana che piaceva a lui), non di meno Tucci vanta una produzione sterminata di scritti, anche in ambito pubblicistico, con articoli per riviste geografiche specializzate che, in parte, vengono ora raccolti nel libro uscito in questi giorni «Il paese delle donne dai molti mariti» (Neri Pozza, pagg. 287, euro 17,50), titolo di un articolo pubblicato ne «La Lettura» del 1936 che, in questo caso, ntitola l'intero volume. Corredato da un apparato fotografico nel quale si segnala una foto del grande Buddha di Bamiyan, in Afghanistan, distrutto dai talebani, che inchioda il lettore non meno della parte testuale, il libro è una sorta di spaccato sociale, culturale, religioso, umano, delle popolazioni che vivono nell'Himalaya soprattutto tibetano. Nella sezione che lo intitola, che indubbiamente evidenzia l'abisso culturale che separa Occidente e Oriente (che poi è il bello delle differenze culturali e, conseguentemente, dell'autentico viaggiare), Tucci descrive la pratica della poliandria nelle aree rurali del Tibet occidentale, pratica che per altro è ancora in auge: «Di mariti quasi tutte ne hanno più d'uno, perché nel Tibet vige ancora il costume della poliandria. Una ragazza sposa non solo il suo fidanzato ma insieme con lui tutti quanti i suoi fratelli e, come se ciò non bastasse, può anche prendersi una specie di assistente, un marito più o meno legale che, essendo scelto per capriccio o per più valide ragioni, finisce presto per diventare la persona più autorevole di questo strano regime familiare. I figli, in mezzo a tanti padri, non sanno distinguerli che in rapporto all'età: e così essi sono gli unici al mondo ad avere un padre seniore e dei padri iuniori. Ma con tutto ciò una grande armonia regna in queste famiglie che non conoscono il tarlo della gelosia o il furore delle passioni. I mariti hanno il loro turno e si avvicendano con rassegnata sottomissione ai voleri della loro signora che di fatto gode di una grande autorità, accresciuta da quello spiccatissimo senso di economia e da quella naturale tendenza a dirigere, amministrare, comandare che è vivissima nelle donne tibetane».
Il passo offre lo spunto per una breve divagazione riguardante la tentazione, ancora presente in Occidente, di interpretare un simile spaccato sociale in senso quasi matriarcale. Ora, premesso che quella del matriarcato è comunque soltanto un'ipotesi giacché non ci sono prove di una sua esistenza nemmeno passata, la poliandria - come ha fatto più volte notare l'antropologa e tibetologa Hildegard Dienberger, docente alla University of Cambridge e profonda conoscitrice della società tibetana contemporanea - non ha niente a che vedere con essa.
Gli spunti di interesse offerti dal libro di Tucci non si esauriscono naturalmente nel capitolo dedicato alle donne dai molti mariti, anzi. Più oltre, sempre riguardo al Tibet, si legge: «in mezzo a così sconsolato paese, in contrade ove vivere è spesso sinonimo di patire, i tibetani sono fra i più sereni popoli della terra. anche gli asceti raminghi, che vanno compiendo certi loro riti notturni paurosi, in mezzo ai cimiteri, per sprofondarsi nella contemplazione della irriducibile insostanzialità di tutte quante le cose e sono coperti di ossa umane e bevono in scatole craniche e suonano trombe fatte con femori, hanno un aspetto così lieto, così beatifico, sono così pronti al sorriso, che incontrarli, nonostante i loro macabri utensili, è quasi sempre un piacere».
È evidente in tutto questo che la conoscenza diretta, e soprattutto la frequentazione, Rabindranath Tagore (Nobel della letteratura nel 1913) e dello storico delle religioni rumeno Mircea Eliade che, come lui, fu spesso in India, non sono semplicemente due dati di interesse biografico, ma ci dicono qualcosa di più dello stile e della sostanza dell'opera di Giuseppe Tucci. Per carità, non si fraintenda: la sua prosa non è affatto lirica, ma la definizione del Tibet come «Altare della terra», o certi articoli che costellano il libro, quali «L'abisso delle Madri» e «Acque cosmiche», rivelano fin da subito in modo inequivocabile che per l'orientalista maceratese la sua fu - come opportunamente evidenziava la mostra tenutasi nel 2004 a Macerata nel centesimo anniversario della nascita - innanzitutto un'esplorazione dell'anima.
Forse non c'è esplorazione vera, viaggio vero, che non siano esplorazioni e viaggi dell'anima e nell'anima, nell'anima mundi e in tutte le sue molteplici manifestazioni: gli spiriti del luogo. Ecco, Tucci fu attratto dalla sfera metafisica dei luoghi così come tanti esploratori, soprattutto anglosassoni, lo furono da quella fisica, fatta salva l'intrinseca magia e ieraticità delle montagne himalayane che fecero dire allo stesso Marco Polo di non essere riuscito a rendere che una minima parte della magie delle terre che aveva attraversato.
Giuseppe Tucci fu un autodidatta straordinariamente erudito, capace di parlare i principali idiomi asiatici e, soprattutto, di non ridurre la sua erudizione a mera conoscenza: se la conoscenza si fonda infatti su una mole di nozioni accumulate orizzontalmente, fu la sapienza, che le attraversa con la verticalità del pensiero, dell'intuizione, dell'analogia e del simbolo, a caratterizzare Tucci. |

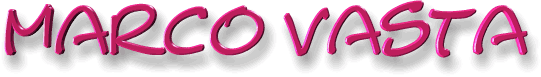


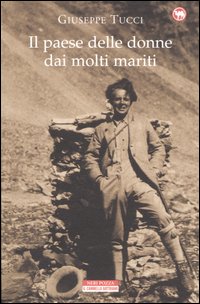 Il paese delle donne dai molti mariti
Il paese delle donne dai molti mariti