|
recensioni di Del Bene, M. L'Indice del 2000, n. 05
Il 7 luglio 1937, l'incidente del ponte di Marco Polo fornì all'armata giapponese del Kwantung, di stanza in Manciuria, il pretesto per scatenare l'invasione della Cina. Entro la fine del mese di luglio le divisioni giapponesi varcarono in più punti il confine della Cina del nord, convergendo su Pechino, che cadde l'8 di agosto. Incapace a porre un freno all'azione dei militari, e sottostimando le reali implicazioni di una guerra con la nazione cinese, il governo di Tokyo non seppe far altro che assecondare quanto avveniva sul campo. Un secondo fronte venne aperto il 13 agosto, con lo sbarco di truppe a Shanghai. Le armate giapponesi, oltre a essere meglio equipaggiate, potevano contare sulla scarsa compattezza del fronte avversario. Difatti, mentre i vertici del Partito comunista cinese avevano chiaramente indicato come prioritaria la guerra all'invasore giapponese, per Chiang Kai-shek (Jang Jieshi) il nemico naturale restava il comunismo. Indicativo il fatto che le relazioni diplomatiche tra Giappone e Cina nazionalista si interruppero solo nel gennaio del 1938.
La conquista di Shanghai, il 12 novembre, aprì la strada all'avanzata delle forze giapponesi verso la capitale nazionalista: Nanchino. Il 20 novembre il governo venne evacuato e la capitale spostata a Chungking (Chongqing). Chi poté lasciò la città, tanto che la popolazione di Nanchino si dimezzò, riducendosi a circa 500.000 unità.
Alla vigilia dell'attacco finale, che ebbe inizio il 4 dicembre, il comando delle truppe giapponesi del settore venne assunto dal generale Asaka, zio dell'imperatore Hirohito. Dopo dieci giorni di combattimenti, Nanchino si consegnò nelle mani dei vincitori, nella speranza di ottenere un trattamento umano. Ma l'ingresso dei soldati giapponesi in città segnò l'inizio di sei settimane di violenza inaudita e apparentemente gratuita.
Secondo stime non verificabili, entro le mura di Nanchino avevano trovato rifugio 80.000 soldati cinesi sbandati, abbandonati dagli ufficiali al loro destino, e diverse migliaia di profughi provenienti dalle campagne circostanti. Tutti i soldati cinesi fatti prigionieri vennero passati per le armi, ma la furia si rivolse anche contro la popolazione civile, nessuno escluso. Al massacro poterono in parte sottrarsi i circa 200.000 cinesi che avevano trovato rifugio nella zona di sicurezza allestita da alcuni cittadini occidentali residenti nella città. Per tutti gli altri fu un incubo di uccisioni, stupri, mutilazioni, e terrore. Non vi sono cifre ufficiali, ma il numero delle vittime viene valutato tra le 40.000 e le oltre 300.000.
Nonostante i tentativi di dissimulare l'accaduto, da parte sia della propaganda dell'epoca sia della corrente negazionista alimentata dalla destra giapponese nel dopoguerra, appare certo che il massacro ebbe carattere sistematico e le violenze vennero non solo tollerate ma incoraggiate dai vertici militari nipponici. Tuttavia, l'effetto di queste atrocità non fu quello, sperato, di atterrire il popolo cinese, bensì quello di unirlo nella lotta contro il Giappone.
===================
recensioni di Gatti, F. L'Indice del 2000, n. 05
Iris Chang porta con vigore alla ribalta mondiale uno dei tragici eventi sottaciuti o, nella migliore delle ipotesi, soltanto sussurrati dagli storici, siano essi giapponesi o statunitensi. Del massacro di Nanchino furono vittime i militari rimasti alla difesa della ex capitale e, soprattutto, la popolazione civile che non abbandonò la città occupata dalle truppe giapponesi il 12 dicembre 1937.
Il massacro, che tanta parte della storiografia giapponese, usando un termine neutro e poco significativo, indica come "incidente", è stato a lungo ignorato. E nella stessa direzione vanno altri drammatici episodi trascurati, quali la vicenda delle comfort women, coreane, taiwanesi, cinesi, indonesiane, olandesi costrette a prostituirsi in campi organizzati dall'esercito giapponese di occupazione dei territori invasi nel corso della Guerra dell'Asia Orientale, iniziata, appunto, con l'invasione della Cina nel luglio del 1937; oppure, gli esperimenti chimici e biologici su cavie umane effettuati in Manciuria dall'Unità 731; o, ancora, la ferocia dei trattamenti a cui furono sottoposti i prigionieri di guerra: si pensi che il numero dei soldati australiani morti per stenti o per fucilazione da parte dei giapponesi supera il 30 per cento, contro meno del 5 per cento dei prigionieri dei nazisti.
Il massacro di Nanchino venne alla ribalta sin dal 1938, denunciato da un Libro bianco cinese, ma cadde nell'indifferenza generale, a causa della incredulità verso l'efferatezza dell'esercito giapponese, e soprattutto perché, riteniamo, in fondo si trattava di un episodio tra "gialli". Inoltre, l'episodio venne denunciato dal console tedesco John Rabe - che si dedicò a sottrarre civili cinesi alla ferocia giapponese - alle autorità del suo paese, cofirmatario con il Giappone del Patto Anticomintern. Infine, la strage fu oggetto di discussione tra i giudici alleati nel corso del processo intentato dai vincitori contro i criminali di guerra dal Tribunale militare di Tokyo. Tuttavia, in quell'occasione, fu deciso di attenuarne l'evidenza.
La pubblicazione del libro di Iris Chang deve fare riflettere in varie direzioni. L'autrice è una giornalista, figlia di emigrati negli Stati Uniti, che udì i racconti sul massacro dai suoi familiari e decise di dare ampia visibilità all'episodio, superando le reticenze della storiografia sul Giappone. Ci si può chiedere perché per decenni non si sia parlato degli "incidenti" sopra elencati, stante il fatto che negli Stati Uniti la schiera degli storici è numerosissima e in grado di accedere a una vasta documentazione non più secretata. I motivi risiedono nel legame, particolarmente forte, che esiste tra la politica statunitense verso il Giappone e la storiografia, una storiografia profondamente colpita, negli anni cinquanta, dalla persecuzione maccartista. Una vicenda, questa, che sfociò nell'affermazione della scuola di Harvard, tutta tesa a coltivare i rapporti con il Giappone in termini di alleanza e, dunque, propensa a depotenziare le polemiche e a darne un'immagine spesso distorta. Non è quindi casuale che le nefandezze della dominazione giapponese in Asia siano riportate all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale da giornalisti o giovani studiosi non inseriti nell'establishment.
Né paia sorprendente la poca visibilità data agli "incidenti" dalla storiografia giapponese. Infatti, sin dal 1945, sono una minoranza sommersa dall'ideologia dominante del regime democratico postbellico gli studiosi che interpretano il processo storico giapponese senza reticenze, indagando su episodi "vergognosi" - e tuttavia da dimenticare, come sostengono molti appartenenti al mondo politico e ai circoli intellettuali nipponici. Questa situazione consente di avanzare la tesi che, oggi, al contrario di quanto succede in Europa, il revisionismo storico non abbia potuto metter radici in Giappone in quanto non vi è mai stata un'approfondita e maggioritaria riflessione sul passato fascista e imperialista negli anni compresi tra le due guerre mondiali, ed è spesso mancata una sua chiara condanna.
La pubblicazione del libro di Iris Chang ha sollevato, negli ambienti intellettuali e accademici giapponesi, grandi polemiche, rinfocolatesi poi nel 1999, quando un editore ne decise la traduzione in giapponese. Gli studiosi negazionisti hanno attaccato violentemente l'autrice, accusandola di far parte di una corrente intellettuale incline a "screditare a livello mondiale il Giappone". Molti altri, invece, si sono collocati in una posizione intermedia, sicché, pur non negando questo e altri episodi, allo stesso tempo hanno sottolineato alcuni errori compiuti dall'autrice; ad esempio, contestandole di aver riportato cifre diverse a proposito del numero di civili e militari cinesi uccisi. In questo, effettivamente, l'autrice non dà prova di un rigore scientifico assoluto; tuttavia, proprio perché studiosi e testimoni non sono concordi, non le sarebbe stato possibile giungere a una conclusione certa. Gli storici di questa tendenza - che potremmo dire "riduzionista" - cercano comunque di minimizzare l'episodio, giocando sulla confusione delle cifre. Il principale esponente di questo gruppo è Hata Ikuhiko, che in un suo articolo, comparso in inglese su "Japan Echo" nell'agosto del 1998, mette appunto a confronto le diverse stime sui civili e i militari uccisi dai giapponesi (da quarantamila a un milione di persone), e su questa base argomenta contro l'opera della Chang, che talora parla di duecentocinquamila vittime, talaltra di trecentomila.
Quanto sostenuto da Hata finisce per rafforzare i negazionisti, che in occasione della programmata pubblicazione in giapponese del libro di Iris Chang hanno enfaticamente riproposto la loro tesi. Con effetti non indifferenti, tanto che l'editore che ne aveva acquistato i diritti di traduzione ha preferito rinunciare, anche a costo di una pesante penale, a diffondere il volume in Giappone. Questa rescissione di contratto ha tuttavia avuto effetti contrari a quanto sperato da quanti l'avevano indotta. Sono infatti tornati sull'argomento alcuni storici di vaglia, primo fra tutti l'ormai ottantenne Fujiwara Akira - presidente dell'associazione degli storici della Seconda guerra mondiale e animatore di un gruppo di ricerca sul massacro di Nanchino -, che nell'ottobre del 1999 ha pubblicato un volume su "Le tredici menzogne dei negazionisti", in cui ha ribadito la sua ferma convinzione che in Giappone il passato non passerà fino a quando il popolo giapponese non farà i conti con la sua storia. E per "fare i conti con la storia" occorre che i giapponesi superino la catarsi collettiva costituita dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, una sorta di alibi per dimenticare le atrocità inflitte dai militari giapponesi alle popolazioni dei territori occupati durante la guerra.
==============================
recensioni di Tomasi, D. L'Indice del 2000, n. 05
Quando all'inizio del 1932, dopo aver occupato la Manciuria, l'esercito giapponese si scontra con quello cinese a Shanghai, tre suoi volontari perdono la vita in un'azione deliberatamente suicida. I tre diventano eroi nazionali e il cinema ne celebra immediatamente l'epica con ben sei film. Il primo di essi uscì sugli schermi il 3 marzo del 1932, l'ultimo il 17, a neanche un mese di distanza dal giorno del tragico evento.
Nel corso degli anni trenta il cinema era diventato in Giappone il principale spettacolo di massa. Lo scoppio della guerra con la Cina (1937) non poteva far sì che una realtà così influente fosse abbandonata a se stessa. Già una settimana dopo l'avvio del conflitto iniziano consultazioni tra apparati statali e studi cinematografici tese a incoraggiare un "rinnovamento spirituale" del popolo giapponese. Dagli incontri prende forma una piattaforma di intenti i cui punti essenziali possono così essere sintetizzati: (1) sradicare la tendenza verso l'individualismo dovuta all'influenza dei film americani ed europei; (2) elevare lo spirito giapponese, esaltare quello familiare, promuovere quello di sacrificio; (3) frenare la tendenza dei giovani, e particolarmente quella delle ragazze, a occidentalizzarsi e a perdere i tipici sentimenti giapponesi; (4) evitare la rappresentazione di un linguaggio, di atteggiamenti e di comportamenti frivoli; (5) sforzarsi di approfondire il senso di rispetto per i padri, i fratelli più anziani e, in generale, tutti i superiori.
Gli accordi sul cinema non sono che parte di un più generale orientamento del paese. Il 1937, ad esempio, è anche l'anno in cui il Ministero della Pubblica Istruzione dà alle stampe il Kokutai no hongi (Principi di politica nazionale), un libro che diverrà obbligatorio nell'insegnamento scolastico e nel quale, secondo principi rigidamente conservatori e antiliberali, si attacca l'individualismo e tutto ciò che è straniero, e si esalta la totale subordinazione del singolo allo Stato.
Una vera e propria legge sul cinema viene però promulgata solo nel 1939. In base a essa ogni dipendente dell'industria cinematografica deve possedere una licenza statale. Le sceneggiature vengono sottoposte a un controllo preventivo, e nella maglie della censura possono cadere anche progetti come Il gusto del riso al the verde di Ozu Yasujiro, che si vede negata l'autorizzazione alle riprese perché colpevole di far mangiare al protagonista, prima della partenza per il fronte, del semplice riso piuttosto che un cibo più appropriato. Chi si oppone ai nuovi provvedimenti, come fece il critico Iwasaki Akira, è semplicemente arrestato.
Sorprende tuttavia come, in questo generale allinearsi dell'industria cinematografica alle esigenze del regime, i primi film giapponesi che seguono l'avviarsi del conflitto siano molto lontani da qualsivoglia enfasi retorica o intento di celebrazione. Ne sono un esempio i due film di Tasaka Tomotaka Cinque esploratori e Terra e soldati, rispettivamente del 1938 e del 1939. I due film, infatti, rifiutano i toni nazionalistici e l'esaltazione dell'eroismo guerriero, pongono l'accento sulla vita quotidiana del soldato, sulla sua psicologia, sulla sua partecipazione materiale al conflitto. Il nemico non è visto con animosità. Il tono dominante si lega strettamente a quel realismo e a quell'umanesimo che avevano caratterizzato alcuni degli esiti migliori del cinema giapponese degli anni precedenti il conflitto.
La censura tuttavia vigila, come testimonia il caso del documentario Soldati che combattono, diretto nel 1939 da Kamei Fumio. L'esercito voleva un film che celebrasse la conquista della città di Hankou e annunciasse nuove e certe vittorie. Al contrario, nel film di Kamei vediamo i volti disperati degli uomini e delle donne a cui è stata bruciata la casa, le lunghe fila di coloro che cercano rifugio nelle campagne, i soldati stremati e ridotti alla fame, le lettere e le fotografie dei figli trovate sui cadaveri dei militari. Il film non venne distribuito, e Kamei fu condannato a due anni di detenzione.
Progressivamente il governo si rese conto che un'oggettiva rappresentazione della guerra era controproducente. Bisognava invece favorire un punto di vista che esaltasse le gesta dei soldati giapponesi e favorisse l'entusiasmo del popolo. Ecco allora nascere da una parte film che celebrano le azioni militari - l'esito migliore è La grande guerra sui mari delle Hawai e della Malesia, di Yamamoto Kajiro (1942), che ricostruisce l'attacco di Pearl Harbour con l'utilizzo di modellini che ancora oggi sorprendono per la loro efficacia realistica e la dimen-
sione spettacolare -, dall'altra pellicole che fanno della Manciuria una terra promessa che avrebbe potuto significare la felicità per milioni di giapponesi - si veda la serie interpretata da Li Hsianglan (in realtà si trattava di un'attrice giapponese, Yamaguchi Toshio) in cui la storia è sempre quella dell'amore di un giapponese e una cinese che finisce con l'avere la meglio sui sentimenti antinipponici di coloro che la vogliono impedire.
Come in ogni paese, poi, la produzione cinematografica degli anni di guerra, comprende anche i cosiddetti film del "fronte interno". L'aspetto qui dominante è quello dell'esaltazione dello spirito di sacrificio, la necessità, per chi è rimasto in patria, di battersi comunque per il paese come se fosse un soldato al fronte. Nessuno dei registi che hanno fatto grande il cinema giapponese negli anni trenta o che continueranno a farlo tale nel dopoguerra si sottrarrà all'obbligo. Ozu realizza negli anni quaranta due dei suoi capolavori, Fratelli e sorelle della famiglia Toda (1941) e C'era un padre (1942). Il primo è la storia della disgregazione di una grande famiglia i cui elementi migliori tenteranno una rinascita spirituale nei territori occupati in Cina; il secondo narra invece del rapporto fra un padre e un figlio, tutto fondato sui sentimenti del sacrificio e della pietà filiale. Mizoguchi, dal canto suo, accetta di mettere in scena il testo classico dell'epica giapponese e della glorificazione dello spirito di sacrificio e fedeltà del samurai, La vendetta dei quarantasette ronin (1941-42), scegliendo tuttavia di mettere in ellissi il momento più epico della narrazione, quello dell'esecuzione della vendetta vera e propria. Kurosawa, infine, dopo il suo film d'esordio Sugata Sanshiro (1943), che riesce a superare le maglie della censura solo grazie al diretto intervento di Ozu - ai funzionari non piaceva l'atteggiamento poco virile del protagonista, un campione di judo che sembrava trarre poco godimento dalle sue vittorie - esalta lo spirito di sacrificio di alcune donne che lavorano presso una fabbrica di lenti destinate ad usi militari in Il più bello (1941). Una semplice ciotola di riso bianco, la messa in ellissi di un'epica scena di battaglia, un maestro di judo che non si compiace troppo della propria bravura sembrano essere gli unici possibili gesti che testimoniano di una pur minima resistenza alla follia dell'ideologia nazional-imperialistica. Altro che raccontare il massacro di Nanchino. |

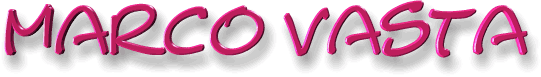

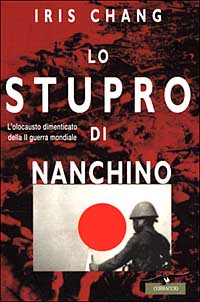
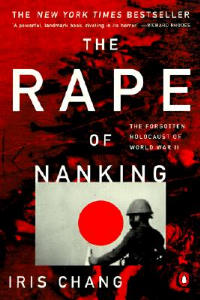 Lo stupro di Nanchino
Lo stupro di Nanchino
